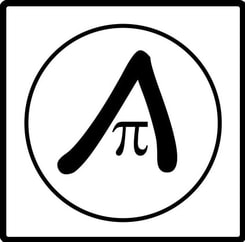|
antropologia e teatro
Ambientate nelle periferie o nel degrado urbano, si raccontano - attraverso un linguaggio meticcio fra il napoletano colto della tradizione barocca e quello del sottoproletario suburbano - le realtà delle protagoniste, in cui la frustrazione imperante crea atmosfere iperreali, sature di sventura. Scomparso giovanissimo, Annibale Ruccello è stato riscoperto e rivalutato negli anni Novanta, divenendo una delle voci più interessanti e originali del teatro italiano della seconda metà del XX secolo.
Le cinque rose di Jennifer (1980); Weekend (1983); Notturno di donna con ospiti (1984); Ferdinando (1985); Piccole tragedie minimali (1986); Anna Cappelli (post. 1987) sono le opere con cui Ruccello ha indagato la trasformazione dell'immaginario attraverso la scomparsa dei miti/riti collettivi. La sua scrittura teatrale, con l'adozione del carattere noir e dei ritmi da thrilling, usa il dialetto non come forma di un teatro di tradizione ma come linguaggio di un teatro di sperimentazione.
La sua stessa presenza, come autore e attore en travesti - Le cinque rose di Jennifer; Notturno di donna con ospiti; Ragazze sole con qualche esperienza - è parte integrante di quella ricerca antropologico-teatrale sui temi dell'identità (culturale e sessuale) in un universo repressivo, contaminato nel linguaggio e nei comportamenti dai modelli di vita borghese.
ferdinando
Ferdinando è la storia della baronessa Clotilde, matura nobildonna che nel 1870, non accettando i Savoia, passa i suoi giorni a letto, malata d’ipocondria, in una villa di periferia. Donna Gesualda, sua cugina povera, la assiste, ricoprendo il doppio ruolo di infermiera e secondino. Tra pillole, ozio e le visite di Don Catellino - il prete, coinvolto in intrighi politici e amori sconvenienti - la vita scorre noiosa. Fino all'arrivo improvviso di Ferdinando, un giovane affascinante ed educato, che scatena l'interesse della piccola comunità, quando afferma di essere un lontano nipote della baronessa.
Tutti se ne innamorano e Ferdinando diventa l'amamte di Don Catellino, della baronessa e anche di Gesualda. Mosse dalla gelosia, Clotilde e Gesualda avvelenano il sacerdote. Ferdinando, però, si rivela non il nipote della baronessa, ma il figlio del notaio venuto per rubare i gioielli che, la baronessa, a sua volta, aveva rubato ad un vecchio amante. Il giovane, ricatta le due donne: i gioielli o lo scandalo. La baronessa, priva di alternative, ri-torna vittima dell'ipocondria.
Lo sguardo Omosessuale
Il vero personaggio gay è quello di Donna Clotilde o meglio è il modo in cui Ruccello costruisce lo sguardo di Gesualda che ci mostra il lato omosessuale. Utilizzando l’immaginario culturale gay, mettendo in scena un personaggio ibrido, contaminato e portatore di desideri contrastanti, costruisce il carattere di Clotilde.
«Fatte mettere ‘e mmane dinte’e cazuneā (Toccandogli il membro nei calzoni) Chisto oìā Chisto ccàā Adda essere sulo d’’o mioā Si saccio ca ‘o daie a quacchedun’ata, t’’o taglioā M’’o mangioā»
Una donna che ha dovuto lasciare la propria città, la famiglia e i suoi diritti a causa della sua personalità, unicità da cui trae anche energia e orgoglio. Affermazione e emarginazione sociale, amore e distruzione fanno de la baronessa la metafora di un mondo che fatica a ricongiungersi con le proprie radici storiche e culturali, che teme il futuro e si nasconde. Unico slancio vitalistico il desiderio, quello sessuale. Desiderare farà ricongiungere Donna Clotilde con la sua vera natura.
Un modo di essere che in chiave camp teatralizza la sua condizione drammatizzando la relazione con gli altri. Si crea così un meta-teatro in cui tutti i personaggi sono descritti attraverso il suo sguardo mentre il suo corpo si espone come una parodia - la malata devota o la seduttrice sensuale - metafora de la resistenza al mondo che cambia.
Sesso e potere
Nel teatro di allora o nei romanzi infatti, i personaggi femminili usavano il sesso come un capitale, solo per poi pentirsi e riscoprire l’amore - pensiamo a La signora delle camelie - oppure, quando esercitavano potere o gestivano denaro, finivano per diventare asessuate, come nel caso di La visita di vecchia signora di Friedrich Dürrenmatt. Nel testo di Ruccello invece, la protagonista, non più giovane, ha potere e sete sessuale, e usa il suo potere per soddisfare la sua fame. Un atteggiamento che la letteratura ha sviluppato più spesso al maschile e che fa di Donna Clotilde una donna che si comporta come un uomo.
gb
Approfondimenti
queer e teatro
Autore
Giovanni Bertuccio
Archivi
Gennaio 2022
Gennaio 2021
Gennaio 2020
Settembre 2019
Marzo 2019
Gennaio 2019
Ottobre 2018
Giugno 2018
Maggio 2018
Aprile 2018
Gennaio 2018
Marzo 2017
Dicembre 2016
Novembre 2016
Ottobre 2016
Settembre 2016
Luglio 2016
Giugno 2016
Maggio 2016
Categorie
Tutti
Action Painting
AIDS
Anna Halprin
Annibale Ruccello
ANNI NOVANTA
Anni Sessanta
Arnulf Rainer
Art Brut
Arte
Arte Dei Folli
ARTE E STRADA
ARTE RELAZIONALE
Artivisive
Azioni
Bodyart
CAMP
Cibele
CIRCO VERTIGO
CLAUDIO ZANOTTO CONTINO
COMPORTAMENTO
COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI
Coreografi
Corpo
CORPO E TEATRO
Cromosomi
Cubo Teatro
Danza
DANZA CONTEMPORANEA
Danza Di Comunità
Danza Di Comunità
DANZA URBANA
DES Danza Educazione Società
Drag
EGRIBIANCODANZA
FESTIVAL
FLIC TEATRO
Franca Zagatti
Gender
Genere
Genetica
GRAFFITISMO
Graphic Novel
Gunter Brus
Hans Prinzhorn
Hermann Nitsch
Il Teatro Dell'altro
Informale
INTERPLAY FESTIVAL
Interviste
ITALIA
Jean Claire
Jean Dubuffet
JEFF KOONS
Judson Dance Theate
Kunst Und Revolution
LACAN
La Nuova Drammaturgia Napoletana
L'art Chez Les Fous
Lesbismo
Luca Silvestrini
Malerei-Selbstbemalung-Selbstverstumme-lung
Mario Mieli
MICHEL FOUCAULT
Monique Witting
MOSTRE
NATURA IN MOVIMENTO
Nicola Galli
NICOLAS BOURRIAUD
NOVECENTO
ORLAN
Otto Muehl
Otto Muhl
Performance
Pollock
PROGETTO ORESTE
Protein Dance Company
PSICODRAMMA
QUEER
Queer E Arte
Queer E Danza
Queer E Teatro
Registi
Renato Barilli
Riti Di Passaggio
Riti Orgistici
Rito E Danza
RUDOLF LABAN
SILVIA BATTAGLIO
STRADA E ARTE
STREET ART
STREET DANCE
Taurobolio
Teatro
TEATRO A CORTE
Teatro Di Orge E Misteri
TEATRO DI STRADA
Teatro Sociale
TECNOLOGIA
TORINO
TRACEY EMIN
Videoart
Videoinstallazione
VUCCIRIA TEATRO
Walter Benjamin
Wiener Aktionisten
Willi Ninja
Wolfli
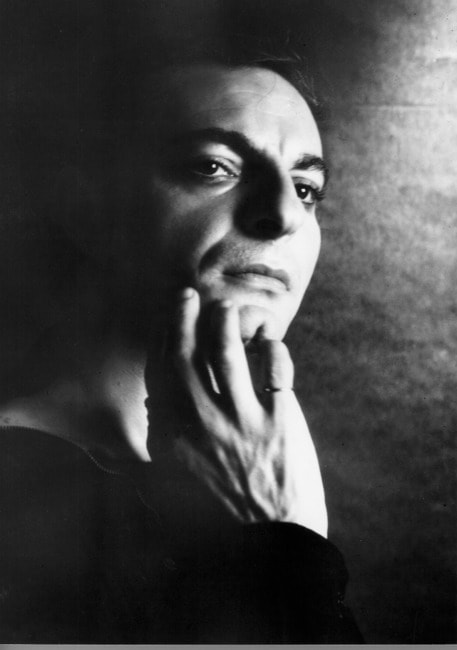
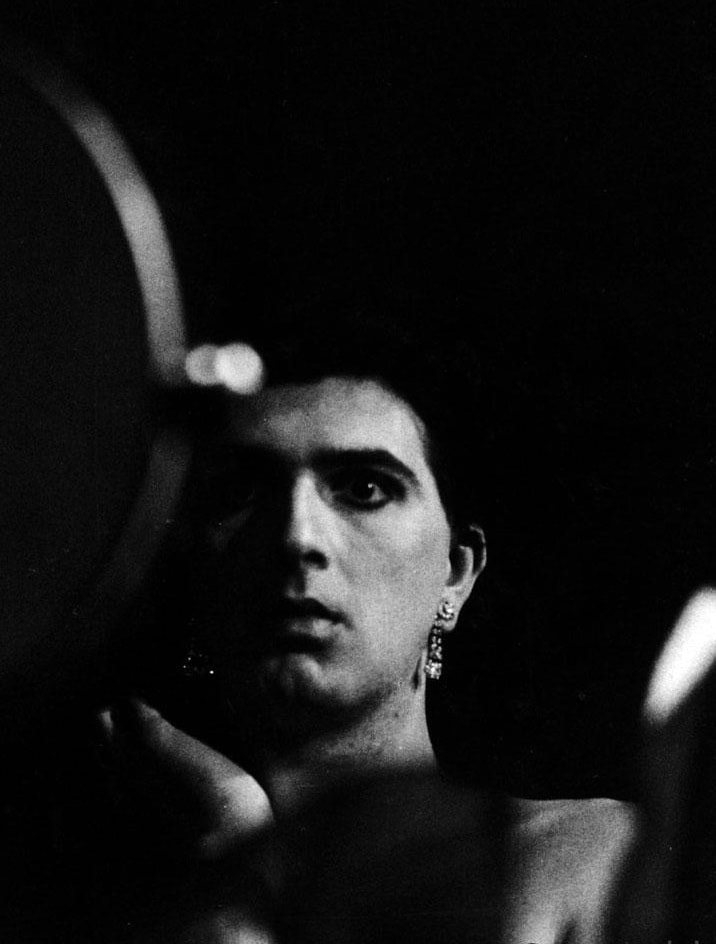
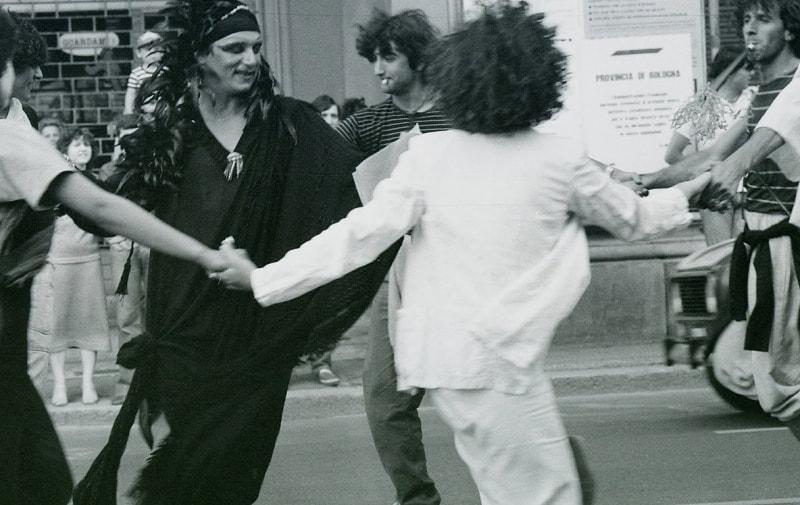



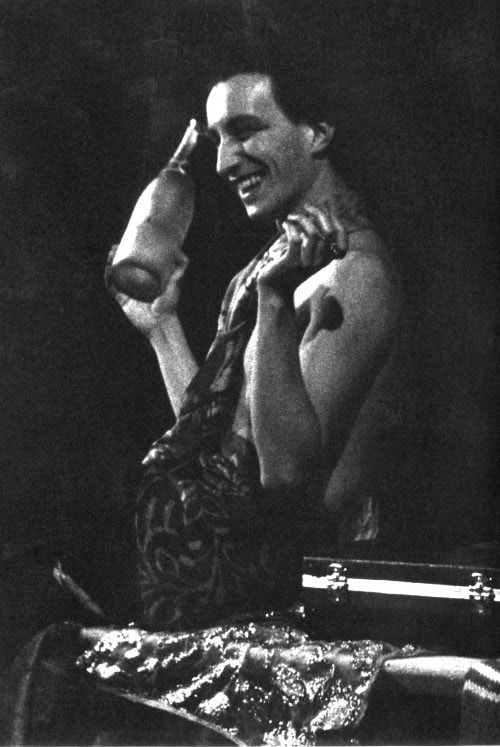

 Feed RSS
Feed RSS