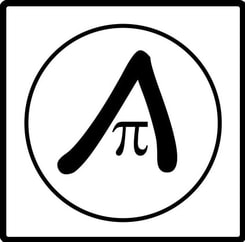Oltre che a nominare autori e a menzionare concetti, quanto detto serve ad affermare come il sentimento del sublime non appartenga a quella sfera di competenze in mano ad un pubblico elitario fatto di artisti, intellettuali e intenditori in grado di apprezzarlo o comprenderlo. Ma piuttosto si pone come quel comune denominatore, che proprio per le sue idiosincrasie: dolore, senso di vuoto, solitudine, orrore, accomuna tutti gli uomini. Perchè tutti gli uomini soffrono, perchè, banalmente, la vita è sofferenza. Ecco, la Nascita della tragedia prima di ogni cosa è una riflessione sulla vita, sulle brutture della vita che possono venir sublimate attraverso l'arte. In un clima di totale crisi della borghesia europea quale poteva essere quello della Germania di fine Ottocento, la vita appare a Friedrich Nietzsche come l'effetto del voler vivere, come un dispiegamento di potenza che coinvolge l'emozione estetica, a sua volta sempre indirizzata verso l'azione. Se i greci hanno affermato la vita e con essa l'opera d'arte, hanno anche realizzato quella liberazione dal dominio della volontà auspicato da Schopenhauer. Il “dire si” alla vita è un'arte suprema che si rispecchia nella tragedia, è l'affermazione della vita stessa, che va accettata in tutti i suoi aspetti, compresi quelli aspri e amari. Nietzsche spoglia totalmente il significato della tragedia da ogni residuo morale e religioso, rovescia l'interpretazione romantica e idealista e la riconduce ad una sfera meramente estetica. L'interpretazione della tragedia, così come l'abbiamo vista analizzata per esempio da Schiller e prima ancora da Aristotele, diventa il suo bersaglio polemico . La tragedia greca è, a suo parere, la prova che i greci non propendessero verso forme di pessimismo o di passiva accettazione, ma piuttosto verso una volontà di vivere forte e prepotente. Secondo Nietzsche, che polemizza tanto con Hegel quanto con Schopenhauer, i greci hanno guardato con coraggio, senza abbandonarsi alla rassegnazione, la terribile storia del mondo. 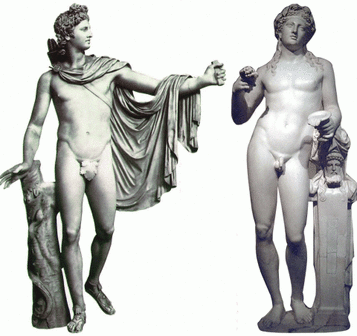 Ne La Nascita della tragedia (1872) ciò che si rimprovera alle interpretazioni precedenti della tragedia greca è il fatto di non aver colto il legame fra apollineo e dionisiaco, che deve essere visto come un rapporto puramente estetico; di non aver colto cioè l'aspetto ludico-estetico del tragico - ciò significa la sua valenza amorale, ateleologica e anche antipessimistica - e di aver privilegiato l'aspetto appunto morale. L'apollineo, quale componente serena, luminosa, dello spirito greco, ma anche strumento della sua disgregazione, immagine del socratismo, della razionalità, e il dionisiaco, quale componente passionale, sofferta, oscura, istintiva, ricerca dell'ignoto e amarezza della verità, visione suprema di ciò che viene riconosciuto nell'esistenza come problematico e infine generatore del mito tragico, si risolvono per Nietzsche nell'unità della tragedia. Tuttavia solo lo sguardo sull'abisso dionisiaco consente il sorgere del grande dramma musicale greco. Il dionisiaco appare, se confrontato con l'apollineo, la vera, originaria ed eterna potenza artistica, forza trasfigurante, la quale consente di percepire quella gioia originaria, che si coglie anche nel dolore e nella distruzione. La tragedia è l'indice che il nulla non va rimosso, ma fronteggiato e trasceso attraverso la creazione. Il piacere estetico del tragico deriva quindi da un gioco di trasposizioni e di rispecchiamenti, da un gioco artistico, che punta al trascendimento del terribile e dell'orrore dell'esistenza. Mai ancora da Aristotele in poi, è stata data una spiegazione dell'effetto tragico, da cui potessero dedurre stati artistici, un'attività estetica degli ascoltatori. Ora pare che la compassione e la paura debbano essere spinte da eventi gravi verso uno sfogo che dia sollievo, ora pare che ci dobbiamo sentire elevati ed esaltati dalla vittoria dei principi buoni e morali, dal sacrificio dell'eroe nel senso di una concezione morale del mondo; e poiché certamente credo che per numerosi uomini proprio questo, e solo questo, sia l'effetto della tragedia, così chiaramente ne risulta che tutti costoro, insieme ai lo interpreti estetici, non hanno sperimentato nulla della tragedia come “arte” somma. In questo modo Nietzsche oltre a rivendicare la preminenza di un'interpretazione estetica, con la sua opera codifica e istituzionalizza tutte le intuizioni che lo hanno preceduto. Dà a tutte quelle un nome nel momento in cui pone il sublime in stretto contatto con Dionisio: ora quel senso d'orrore, quella bellezza del brutto, quel rimanere impotenti difronte alla verità delle bassezze umane ha un patrono: il dio delfico riesumato da Nietzsche. Il satiro come coreuta dionisiaco vive in una realtà religiosamente riconosciuta, sotto la sanzione del mito e del culto. Che la tragedia cominci con lui, che attraverso lui parli la saggezza dionisiaca della tragedia, è un fenomeno per noi tanto sorprendente, quanto lo è in genere la nascita della tragedia dal coro. Forse si può stabilire un unto di partenza per la nostra considerazione, se pongo l’affermazione che il Satiro, il finto essere naturale, sta rispetto all’uomo civile nello stesso rapporto in cui la musica dionisiaca sta rispetto alla civiltà […] L’uomo civile greco si sentiva annullato al cospetto del coro dei Satiri: e l’effetto immediato della tragedia dionisiaca consiste in questo, che lo Stato e la società, e in genere gli abissi fra uomo e uomo cedono a un soverchiante sentimento di unità che riconduce al cuore della natura […] Con questo coro trova consolazione il greco profondo, dotato in modo unico per la sofferenza più delicata e più aspra, che ha contemplato con sguardo tagliente il terribile processo di distruzione della storia universale, come pure la crudeltà della natura, e corre il pericolo di anelare a una buddistica negazione della volontà. Lo salva l’arte, e mediante l’arte lo salva a sé, la vita. giovanni bertuccio Uno dei temi che sono maggiormente in grado di mostrare la molteplicità delle fonti e dei problemi relativi all'inizio di un discorso estetico è probabilmente quello del sublime, in cui argomenti poetici, filosofici, etici e artistici in esso si fondono, o si scontrano, in direzioni spesso ambigue e confuse. Il sublime rischia anzi di presentarsi, sul piano storico, proprio come la storia di un equivoco, in cui vi è sempre timore dell'arbitrarietà critica quando, sotto un solo nome, si racchiude l'incrocio di più discipline. Non potendo soffermarci su un percorso lineare ed esaustivo sulle teorie nate attorno al sublime, ci limiteremo a prendere in considerazione le idee di alcuni autori che, attraverso i secoli e le correnti, hanno guardato da diversi punti di vista la questione prima del Novecento. Certo è che soltanto a partire dal Settecento il sublime diviene una vera e propria categoria estetica, contrapponendosi alla centralità del bello oppure rafforzandone le potenzialità estetiche. Il godimento estetico nelle belle forme, nella grazia e nella proporzione lasciava, nel Settecento, anche se in fase germinale, il posto alla predilezione verso un nuovo sentimento, quello del sublime, in grado di aprire, al nostro interno, un orizzonte oscuro, lo stesso che lega la natura alle passioni dell'uomo. Ed è seguendo questa direzione che Edmund Burke con la sua Indagine filosofica sull'origine delle nostre idee di Sublime e Bello, rappresenta un fondamentale passaggio storico-teorico del concetto. Nella ricerca di Burke il sublime è definito come <<ciò che produce la più forte emozione che l'animo sia in grado di sentire>>; emozione che tuttavia non deriva da una “reale” esperienza negativa ma da una situazione in cui, pur avendo una ben precisa idea del dolore e del pericolo, non né siamo a diretto contatto. Di fronte a sentimenti quali paura, dolore o orrore, lo stupore che invade e paralizza non deve condurre alla distruzione del soggetto, bensì deve indurre la consapevolezza di un dolore “mancato”, che si guarda a distanza. Il piacere generato da questa situazione, sublime perché ambigua, non è per Burke un vero e proprio piacere “positivo” vista la sua relazione con il dolore. Il sublime si pone dunque come istinto di auto-preservazione in tutte quelle situazioni in cui il soggetto è in uno stato di “privazione”, ad esempio di fronte all'infinito, al vuoto, all'oscurità, alla solitudine o al silenzio. È chiaro come questo tipo di sensazione, o meglio sensazioni al plurale, si contrappongano nettamente al concetto di bello, sia nei risvolti estetici che artistici. Il bello non è più forma, proporzione con Burke. Il bello non deve soddisfare più il piacere degli occhi attraverso giochi cromatici o trovate prospettiche. Più che condizioni esterne il bello deve soddisfare necessità interne. Dalla messa in pratica di regole che ne decretavano la bellezza, l'arte più che essere vista, da qui in poi, e molto lentamente, andava sentita financo vissuta. Ovviamente le riflessioni estetiche sul sublime andarono alimentandosi, il secolo di Burke si chiuse con le osservazioni kantiane e le opere di Schiller e Schelling; l'Ottocento caricò di nuova enfasi le definizioni, dando vita alle opere di Hegel e Schopenhauer, con le quali il divario arte vita andava rimpicciolendosi. Consideriamo sinteticamente le opere dei due. Nella sua Estetica, Hegel pone il sublime, concordando con i suoi predecessori, come la manifestazione estetica di un contrasto fra finito e infinito.  Il sublime diviene il tentativo di esprimere l'infinito, senza che tuttavia si riesca a trovare nel mondo delle apparenze un oggetto che offra per tale infinità un'adeguata rappresentazione. Nel sublime hegeliano, più che il dolore interiore e il tormento etico introdotti in Kant, è presente una tensione inappagata, che spinge verso il superamento delle situazioni sublimi attraverso il divenire dello spirito artistico, in quanto l'arte è in grado di restaurare l'assoluto. Ne Il mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer, invece vede il sublime come vicino a quegli oggetti che invitano con la loro forma alla pura contemplazione ma che, al tempo stesso, per la loro grandezza e “forza superiore”, hanno un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti della volontà umana. È dunque proprio con Schopenhauer che il termine sublime tende ad allontanarsi dal contesto estetico in cui si era inserito da più di un secolo, per presentarsi come una grande metafora della condizione umana, come una sorta di stato esistenziale al tempo stesso eccelso e minaccioso.1 Con i pensatori romantici l'attenzione della riflessione filosofica si sposta dalla natura, come oggetto di indagine, all'arte. Originale, nel periodo romantico, è soprattutto il legame tra le diverse forme, dettato non dalla ragione, ma dal sentimento e dalla ragione, legame che non mira a escludere le contraddizioni o a risolvere le antitesi (finito/infinito, intero/frammento, vita/morte, mente/corpo), ma ad accoglierle in un insieme unitario. La bellezza cessa di essere forma e diventa bello l'informe, il caotico. Non interessa più l'appagamento degli occhi, ma si è più inclini alla fascinazione di ciò che viene suscitato nell'animo dello spettatore. Con il progredire della società e il suo, conseguente, complicarsi, cambia inevitabilmente, anche il singolo che vive in questa società. L'uomo moderno non è più, come si credeva, il frutto di un'evoluzione ma, comincia a insinuarsi l'idea che l'uomo sia il prodotto di una degenerazione della purezza originaria, e poste cosi le cose, la battaglia contro la civiltà andava combattuta con armi nuove, non più trattate dall'arsenale della ragione (che è prodotta dalla medesima degenerazione), ma far prevalere le armi del sentimento, della natura. La natura stessa, contrapposta all'artificio della storia appariva oscura, informe, misteriosa: non si lascia catturare da forme precise e nette, ma travolge lo spettatore con visioni grandiose e sublimi. Per questo non si descrive la bellezza della natura, ma la si sperimenta direttamente, la si intuisce lanciandovisi dentro. I significati classici di bellezza, dunque, sono definitivamente ridiscussi e si giunge a ipotizzare, come accadrà in Victor Hugo, che siano la molteplicità delle cose brutte, e non l'armonia della bellezza, le sole capaci di dire la complessità dell'arte. Anche Baudelaire, esaltando il senso simbolico del bello, ne afferra anche la contingenza e di conseguenza la pluralità di modi e categorie attraverso le quali la sua forza può esplicarsi. La bellezza apollinea è ormai attraversata, come dimostra la Nascita della tragedia di Nietzsche, da un impulso dionisiaco, spirito di ebrezza e di trasgressione eccedente. Con quest'opera si chiude il secolo dei romantici e si saluta da vicino il Novecento portando in eredità la distruzione dell'idea classica del bello e della sua autonoma pienezza simbolica. Elementi che avranno pieno compimento nel corso di tutto XXI sec., ma che già, all'epifania del nuovo secolo, trovarono nuova linfa nei movimenti d'avanguardia: Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo, Futurismo contestarono fermamente la possibilità di una forma assoluta per il bello e ancor più radicalmente negarono che l'arte possa trovare nella bellezza un principio di sintesi o di definizione. giovanni bertuccio Sempre più spesso nelle ultime decadi - ma come basso ostinato per tutta la storia dell'arte - piccoli mostri o ibridi uomo-animale hanno occupato tele, sono fuori usciti dalla materia degli scultori, hanno raggiunto la videoarte, sono stati immortalati dalla fotografia. Un mondo fantastico e favolistico che, scacciato dalle società odierne e nascondendosi nei boschi, pretende oggi, a ragione, una sua ricollocazione. Ma perché, un mondo che insegue la bellezza e ha fatto del suo cavallo di battaglia in onore alla civiltà la lontananza dell'uomo dalla sua natura animale, dovrebbe partorire invece, come una serpe in seno, il suo esatto opposto? Cercheremo di scoprirlo e affronteremo anche la scoperta di un'arte devota, consacrata, forse inconsapevolmente, alle istanze dionisiache. Risponderemo alle domande: perché ibridi? Da dove arrivano? Cosa significano? Quale messaggio nasconde questo tipo d'arte? Quale percorso nel panorama della storia delle arti? Cominciamo dunque il viaggio alla scoperta dell'arte dionisiaca e della conseguente profezia dell'uomo nuovo. 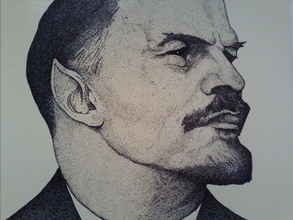 La Grecia. Preludio e coda Nella mitologia greca – civiltà che ci ha fondati e ci ha impartito le migliori lezioni, che ci portiamo dentro, inconapevolmente, nel nostro dna -, gli ibridi uomo-animale incarnano spesso concetti legati al pericolo, alla sfida e alla morte. In passato si trattava per lo più di figure femminili (sfingi, meduse, sirene), dalla bellezza pericolosa, in grado di sedurre e uccidere. Il loro potere consisteva nel melodioso e letale canto, e venivano raffigurate con il corpo di uccello e il volto da donna. Nelle epoche successive si sono trasformate diventando con corpo da donna e coda, o coda di pesce, incarnando universalmente il simbolo della seduzione e del fascino femminile. Legate alla conoscenza e al mistero della vita e della morte, in età moderna, il fascino di queste creature esplose in ambito simbolista, con la creazione del mito della femme fatale: la donna la cui doppia natura ammalia e distrugge, e sopravvive fino ai nostri giorni, interpretato da artisti di tutte le epoche, da Max Klinger a Paul Delvaux; da Gustav Moreau, Dante Gabriel Rossetti e Kiki Smith fino alla parodia di Jeff Koons.  Accanto a questa galleria di figure femminili, una quadreria di figure maschili come il Minotauro, i Satiri dionisiaci, le creature mitologiche, con corpo maschile e testa di toro, incarnano fin dall'antichità concetti legati all'istintualità, alla violenza, all'erotismo. Per il suo rimando all'istinto, la figura del mostro di Creta si è sposata perfettamente con la poetica surrealista prima e contemporanea poi, volta all'affermazione del potere dell'inconscio, in quanto i Satiri e i Centauri e tutto il corteo dionisiaco, non stanno né coi mortali né con gli dei immortali, ma vivono in una sorta di interregno tra quello umano e quello divino. L'idea di un'umanità pre-umana, o para-umana, abitata dagli dei dell'Olimpo e da figure fantastiche si associa all'ideale di un stato di natura assoluto. Una zona mitica che sta al di qua e al di là di ogni "disagio della civiltà", un'altra realtà che ci accompagna, un'alterità appunto. Sono i tempi di una sessualità violenta e non censurata, dell'erotismo sfrenato, della gioia festosa dell'ebbrezza. Della danza, della musica, ma anche della violenza ferina, non mitigata, selvaggia. Sono anche i mondi della contemplazione dell'armonia arcadica, condizione cui gli uomini aspireranno quale assoluto da raggiungere. L'Arcadia, quindi, è un luogo dell'immaginario ma anche una condizione dello spirito. E se è vero che, come diceva Panofsky, anche nell'Arcadia c'è la morte, si tratterà di una morte accettata come un evento naturale, culmine di un'esistenza ciclica perché mitica.  Infine, il ruolo dell'uomo-animale, come essere legato alla divinità o dotato di facoltà superiori, fa si che nella mitologia greca, il centauro Chirone sia un essere civilizzato. E' amico degli uomini ed è maestro di eroi e dei, infatti uno dei suoi compiti è quello della formazione di Achille. Qui, Chirone rappresenta l'ibrido mitico dotato di una saggezza superiore, e qui diviene metafora per una critica sociale, punto nevralgico e significato dell'arte dionisiaca. E sotto questa luce lo hanno visto artisti quali Gustave Moreau, Jacob Jordaens e Jacek Malczeski, in cui l'ibrido è dotato di una creatività che all'uomo/artista è sconosciuta. Proprio nell'opera di Malczewski, infatti, il satiro sussurra all'orecchio del suonatore la "nota sconosciuta", un segreto magico, mostrando il suo legame con le forze divine. Perché allora, concordando con Aby Waburg, l'uomo dovrebbe collocarsi al di sopra degli animali? Gli uomini sono soltanto capaci di fare qualcosa, mentre l'animale è capace di esprimere ciò che è, in modo naturale. giovanni bertuccioBattuage è un non luogo dell'immaginazione, un confine - urinatoi, toilett pubbliche, autogrill, parcheggi, parchi, autostrade, cruising - in cui le differenze si dissolvono. Valgono ancora, secondo te, le categorie lgbt in questi luoghi? Nel senso il padre di famiglia che va a trans e svolge il ruolo passivo, e tornato a casa consuma un rapporto con la moglie, è gay o no? Forse che la dipendenza da sesso e sé stessi, insieme alla necessità di evadere dalle gabbie sociali, va al disopra dei generi e delle categorie? Assolutamente si. BATTUAGE racconta di come la ricerca spasmodica del sesso può tramutarsi in una tendenza del tutto anti-erotica che rivela la morte stessa del sesso, o meglio dell’eros. La nostra società è sempre più virtuale e più solitaria e l’individuo finisce per instaurare un rapporto erotico con la propria immagine, reiterando diverse declinazioni di autoerotismo . Anche quando si parla di un rapporto con un altro corpo, un altro spirito, un’altra persona. C’è sempre meno voglia di esporsi e di condividere. Il Maschio. Quello che racconti, sia nel primo che nel secondo spettacolo, è un mondo non solo omosessuale, ma prettamente maschile. Dove maschile è da intendersi come il genere della razza uomo. Dunque l'uomo istintivo ed animale. Libero e cacciatore? Incapace, forse denunci in Battuage, di rapporti sani e puri, “fin che morte non ci separi”? Nei nostri spettacoli c’è sicuramente il risultato di un interrogativo aperto su che cosa sia oggi maschile e femminile. Io credo che maschile nella nostra società voglia dire solo in apparenza maggiore libertà. Piuttosto coincide spesso con maggiore (auto)-imposizione. Credo che questa società sia strettamente fondata solo su un aspetto particolare del maschile legato più al POTERE e all’imposizione del potere sugli altri. Ma machile è davvero solo questo? La società capitalista e consumista sembra valorizzarne solo questo aspetto. E noi uomini finiamo per perdere di vista il resto. Il potere si trasforma troppo presto in affanno distruttivo. La donna. A volte appare come Medea, genitrice e divoratrice al contempo della propria prole. Indifferente in "Io mai ninete con nessuno avevo fatto", “magnaccio” in "Battuage". Mentre la si crede, apparentemente, vittima della società dei maschi, la moglie, in Battuage, pone fine allo squallore del marito, uccidendolo. E' la donna che deve prendere posizione, nella speranza di un futuro meno ipocrita? Io credo tantissimo nelle donne e credo di amarle molto. Al di la dei risvolti legati alla storia raccontata da Battuage credo che la donna debba prendere posizione (ma bisogna anche che gli sia concesso!). La società è maschio. Le donne hanno bisogno di scrollarsi di dosso l’etichetta che storicamente le dipingono come sesso debole, inferiore rispetto all’uomo. Ma questa è la donna dipinta da una società maschilista. Io auspico ad una società maggiormente concentrata sull’universo femminile in quanto portatore dei veri valori fondanti dell’umanità. Auspicherei ad una società fondata più sull’empatia che sul potere. Ma non bisogna dare per scontato che anche per le donne “il femminile” coincida sempre e automaticamente con il genere femminile. Molto spesso la donna finisce (per non rimanere schiacciata) per aderire perfettamente al modello maschile, a reiterarlo e a svilire anche la sua figura di donna. Dio. Con lui hai un rapporto ambivalente. Sembri deriderlo quando lo associ ai dogmi della religione (sicurmanete d'impatto la preghiera in un gloryhole e le promesse degli sposi simulando l'amplesso ondeggiando il bacino), inseguirlo, invece, quando non resta altro che cercare dentro sé stessi un sentimento spirituale. Forse il Dio che ci ha fatto a sua immagine? Il rapporto con la spiritualità, con il divino è indubbiamente qualcosa per me di aperto e non ancora del tutto definito. Mi definisco ateo o ancora meglio non credo nella religione, ma questo non significa che la società (e io stesso) non abbia bisogno di coltivare la propria spiritualità, anzi. Personalmente non riesco ad aderire a qualcosa di dogmatico e precostituito cosi forse dentro il nostro percorso artistico c’è tanta conflittualità con questo dio. Tanto desiderio di sentirlo e anche di rimpianto di non averlo al nostro fianco. Così spesso dio è un urlo propagato nel vuoto. La società. Il protagonista è un perfetto prodotto della società odierna. E' Ruby e Fabrizio Corona. E' l'universitaria/o che si vende per un cellulare. E' il ragazzo/a che si esibisce in cam nella sua camera. Salvatore è espressione di una generazione miope e sorda, che non chiede e non domanda. Che usa il suo libero arbitrio solo per scegliere, individualmente, brand imposti da altri e sognare di arricchirsi diventando famoso in preda la lobotomizzazione televisiva? Purtroppo tutti questi sono i modelli proposti di ‘nuova classe media’ che si sta sempre più imponendo e delineando non tanto da un punto di vista culturale come è stata storicamente nel ‘900 ma a partire da una sua reiterata e consapevole degenerazione. Siamo ben al di là sotto del concetto di cultura di massa. Una volta la tv assolveva a compiti ben più nobili. L’intrattenimento era anche culturale. Oggi invece c’è la precisa volontà di proporre modelli beceri e a cui spesso si finisce per aderire perché non se ne hanno degli altri così forti. Ma perché? È la domanda che non trova risposta. Prima per ‘agire’ quasi sempre bisognava unirsi e farlo nel contesto della collettività. Oggi si ‘agisce’ in una dimensione pubblica fintamente collettiva (la piazza pubblica dei social network) ma che rivela solo la nostra solitudine e il nostro isolamento. E tutto questo non è affatto inconsapevole. Manchiamo sempre più l’appuntamento con una dimensione carnale delle cose. Con una dimensione creativa e di confronto con l’altro. E finiamo per sprofondare dentro noi stessi arrivando a deformare la nostra stessa percezione della realtà. Siamo tutti delle star. Ci affanniamo ad essere “speciali”. E che cosa resta di noi? gb |
AutoreGiovanni Bertuccio Archivi
Gennaio 2022
Categorie
Tutti
|
ART IS PRESENT
Art is Present
|











 Feed RSS
Feed RSS