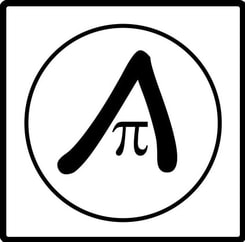Oltre che a nominare autori e a menzionare concetti, quanto detto serve ad affermare come il sentimento del sublime non appartenga a quella sfera di competenze in mano ad un pubblico elitario fatto di artisti, intellettuali e intenditori in grado di apprezzarlo o comprenderlo. Ma piuttosto si pone come quel comune denominatore, che proprio per le sue idiosincrasie: dolore, senso di vuoto, solitudine, orrore, accomuna tutti gli uomini. Perchè tutti gli uomini soffrono, perchè, banalmente, la vita è sofferenza. Ecco, la Nascita della tragedia prima di ogni cosa è una riflessione sulla vita, sulle brutture della vita che possono venir sublimate attraverso l'arte. In un clima di totale crisi della borghesia europea quale poteva essere quello della Germania di fine Ottocento, la vita appare a Friedrich Nietzsche come l'effetto del voler vivere, come un dispiegamento di potenza che coinvolge l'emozione estetica, a sua volta sempre indirizzata verso l'azione. Se i greci hanno affermato la vita e con essa l'opera d'arte, hanno anche realizzato quella liberazione dal dominio della volontà auspicato da Schopenhauer. Il “dire si” alla vita è un'arte suprema che si rispecchia nella tragedia, è l'affermazione della vita stessa, che va accettata in tutti i suoi aspetti, compresi quelli aspri e amari. Nietzsche spoglia totalmente il significato della tragedia da ogni residuo morale e religioso, rovescia l'interpretazione romantica e idealista e la riconduce ad una sfera meramente estetica. L'interpretazione della tragedia, così come l'abbiamo vista analizzata per esempio da Schiller e prima ancora da Aristotele, diventa il suo bersaglio polemico . La tragedia greca è, a suo parere, la prova che i greci non propendessero verso forme di pessimismo o di passiva accettazione, ma piuttosto verso una volontà di vivere forte e prepotente. Secondo Nietzsche, che polemizza tanto con Hegel quanto con Schopenhauer, i greci hanno guardato con coraggio, senza abbandonarsi alla rassegnazione, la terribile storia del mondo. 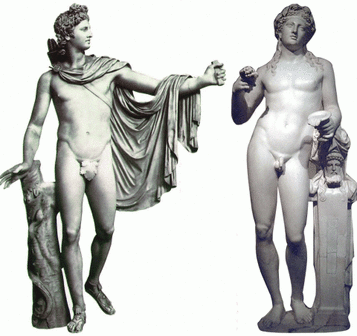 Ne La Nascita della tragedia (1872) ciò che si rimprovera alle interpretazioni precedenti della tragedia greca è il fatto di non aver colto il legame fra apollineo e dionisiaco, che deve essere visto come un rapporto puramente estetico; di non aver colto cioè l'aspetto ludico-estetico del tragico - ciò significa la sua valenza amorale, ateleologica e anche antipessimistica - e di aver privilegiato l'aspetto appunto morale. L'apollineo, quale componente serena, luminosa, dello spirito greco, ma anche strumento della sua disgregazione, immagine del socratismo, della razionalità, e il dionisiaco, quale componente passionale, sofferta, oscura, istintiva, ricerca dell'ignoto e amarezza della verità, visione suprema di ciò che viene riconosciuto nell'esistenza come problematico e infine generatore del mito tragico, si risolvono per Nietzsche nell'unità della tragedia. Tuttavia solo lo sguardo sull'abisso dionisiaco consente il sorgere del grande dramma musicale greco. Il dionisiaco appare, se confrontato con l'apollineo, la vera, originaria ed eterna potenza artistica, forza trasfigurante, la quale consente di percepire quella gioia originaria, che si coglie anche nel dolore e nella distruzione. La tragedia è l'indice che il nulla non va rimosso, ma fronteggiato e trasceso attraverso la creazione. Il piacere estetico del tragico deriva quindi da un gioco di trasposizioni e di rispecchiamenti, da un gioco artistico, che punta al trascendimento del terribile e dell'orrore dell'esistenza. Mai ancora da Aristotele in poi, è stata data una spiegazione dell'effetto tragico, da cui potessero dedurre stati artistici, un'attività estetica degli ascoltatori. Ora pare che la compassione e la paura debbano essere spinte da eventi gravi verso uno sfogo che dia sollievo, ora pare che ci dobbiamo sentire elevati ed esaltati dalla vittoria dei principi buoni e morali, dal sacrificio dell'eroe nel senso di una concezione morale del mondo; e poiché certamente credo che per numerosi uomini proprio questo, e solo questo, sia l'effetto della tragedia, così chiaramente ne risulta che tutti costoro, insieme ai lo interpreti estetici, non hanno sperimentato nulla della tragedia come “arte” somma. In questo modo Nietzsche oltre a rivendicare la preminenza di un'interpretazione estetica, con la sua opera codifica e istituzionalizza tutte le intuizioni che lo hanno preceduto. Dà a tutte quelle un nome nel momento in cui pone il sublime in stretto contatto con Dionisio: ora quel senso d'orrore, quella bellezza del brutto, quel rimanere impotenti difronte alla verità delle bassezze umane ha un patrono: il dio delfico riesumato da Nietzsche. Il satiro come coreuta dionisiaco vive in una realtà religiosamente riconosciuta, sotto la sanzione del mito e del culto. Che la tragedia cominci con lui, che attraverso lui parli la saggezza dionisiaca della tragedia, è un fenomeno per noi tanto sorprendente, quanto lo è in genere la nascita della tragedia dal coro. Forse si può stabilire un unto di partenza per la nostra considerazione, se pongo l’affermazione che il Satiro, il finto essere naturale, sta rispetto all’uomo civile nello stesso rapporto in cui la musica dionisiaca sta rispetto alla civiltà […] L’uomo civile greco si sentiva annullato al cospetto del coro dei Satiri: e l’effetto immediato della tragedia dionisiaca consiste in questo, che lo Stato e la società, e in genere gli abissi fra uomo e uomo cedono a un soverchiante sentimento di unità che riconduce al cuore della natura […] Con questo coro trova consolazione il greco profondo, dotato in modo unico per la sofferenza più delicata e più aspra, che ha contemplato con sguardo tagliente il terribile processo di distruzione della storia universale, come pure la crudeltà della natura, e corre il pericolo di anelare a una buddistica negazione della volontà. Lo salva l’arte, e mediante l’arte lo salva a sé, la vita. giovanni bertuccio |
AutoreGiovanni Bertuccio Archivi
Gennaio 2022
Categorie
Tutti
|
ART IS PRESENT
Art is Present
|
 Feed RSS
Feed RSS