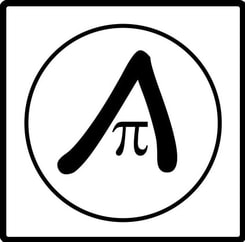Uno dei temi che sono maggiormente in grado di mostrare la molteplicità delle fonti e dei problemi relativi all'inizio di un discorso estetico è probabilmente quello del sublime, in cui argomenti poetici, filosofici, etici e artistici in esso si fondono, o si scontrano, in direzioni spesso ambigue e confuse. Il sublime rischia anzi di presentarsi, sul piano storico, proprio come la storia di un equivoco, in cui vi è sempre timore dell'arbitrarietà critica quando, sotto un solo nome, si racchiude l'incrocio di più discipline. Non potendo soffermarci su un percorso lineare ed esaustivo sulle teorie nate attorno al sublime, ci limiteremo a prendere in considerazione le idee di alcuni autori che, attraverso i secoli e le correnti, hanno guardato da diversi punti di vista la questione prima del Novecento. Certo è che soltanto a partire dal Settecento il sublime diviene una vera e propria categoria estetica, contrapponendosi alla centralità del bello oppure rafforzandone le potenzialità estetiche. Il godimento estetico nelle belle forme, nella grazia e nella proporzione lasciava, nel Settecento, anche se in fase germinale, il posto alla predilezione verso un nuovo sentimento, quello del sublime, in grado di aprire, al nostro interno, un orizzonte oscuro, lo stesso che lega la natura alle passioni dell'uomo. Ed è seguendo questa direzione che Edmund Burke con la sua Indagine filosofica sull'origine delle nostre idee di Sublime e Bello, rappresenta un fondamentale passaggio storico-teorico del concetto. Nella ricerca di Burke il sublime è definito come <<ciò che produce la più forte emozione che l'animo sia in grado di sentire>>; emozione che tuttavia non deriva da una “reale” esperienza negativa ma da una situazione in cui, pur avendo una ben precisa idea del dolore e del pericolo, non né siamo a diretto contatto. Di fronte a sentimenti quali paura, dolore o orrore, lo stupore che invade e paralizza non deve condurre alla distruzione del soggetto, bensì deve indurre la consapevolezza di un dolore “mancato”, che si guarda a distanza. Il piacere generato da questa situazione, sublime perché ambigua, non è per Burke un vero e proprio piacere “positivo” vista la sua relazione con il dolore. Il sublime si pone dunque come istinto di auto-preservazione in tutte quelle situazioni in cui il soggetto è in uno stato di “privazione”, ad esempio di fronte all'infinito, al vuoto, all'oscurità, alla solitudine o al silenzio. È chiaro come questo tipo di sensazione, o meglio sensazioni al plurale, si contrappongano nettamente al concetto di bello, sia nei risvolti estetici che artistici. Il bello non è più forma, proporzione con Burke. Il bello non deve soddisfare più il piacere degli occhi attraverso giochi cromatici o trovate prospettiche. Più che condizioni esterne il bello deve soddisfare necessità interne. Dalla messa in pratica di regole che ne decretavano la bellezza, l'arte più che essere vista, da qui in poi, e molto lentamente, andava sentita financo vissuta. Ovviamente le riflessioni estetiche sul sublime andarono alimentandosi, il secolo di Burke si chiuse con le osservazioni kantiane e le opere di Schiller e Schelling; l'Ottocento caricò di nuova enfasi le definizioni, dando vita alle opere di Hegel e Schopenhauer, con le quali il divario arte vita andava rimpicciolendosi. Consideriamo sinteticamente le opere dei due. Nella sua Estetica, Hegel pone il sublime, concordando con i suoi predecessori, come la manifestazione estetica di un contrasto fra finito e infinito.  Il sublime diviene il tentativo di esprimere l'infinito, senza che tuttavia si riesca a trovare nel mondo delle apparenze un oggetto che offra per tale infinità un'adeguata rappresentazione. Nel sublime hegeliano, più che il dolore interiore e il tormento etico introdotti in Kant, è presente una tensione inappagata, che spinge verso il superamento delle situazioni sublimi attraverso il divenire dello spirito artistico, in quanto l'arte è in grado di restaurare l'assoluto. Ne Il mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer, invece vede il sublime come vicino a quegli oggetti che invitano con la loro forma alla pura contemplazione ma che, al tempo stesso, per la loro grandezza e “forza superiore”, hanno un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti della volontà umana. È dunque proprio con Schopenhauer che il termine sublime tende ad allontanarsi dal contesto estetico in cui si era inserito da più di un secolo, per presentarsi come una grande metafora della condizione umana, come una sorta di stato esistenziale al tempo stesso eccelso e minaccioso.1 Con i pensatori romantici l'attenzione della riflessione filosofica si sposta dalla natura, come oggetto di indagine, all'arte. Originale, nel periodo romantico, è soprattutto il legame tra le diverse forme, dettato non dalla ragione, ma dal sentimento e dalla ragione, legame che non mira a escludere le contraddizioni o a risolvere le antitesi (finito/infinito, intero/frammento, vita/morte, mente/corpo), ma ad accoglierle in un insieme unitario. La bellezza cessa di essere forma e diventa bello l'informe, il caotico. Non interessa più l'appagamento degli occhi, ma si è più inclini alla fascinazione di ciò che viene suscitato nell'animo dello spettatore. Con il progredire della società e il suo, conseguente, complicarsi, cambia inevitabilmente, anche il singolo che vive in questa società. L'uomo moderno non è più, come si credeva, il frutto di un'evoluzione ma, comincia a insinuarsi l'idea che l'uomo sia il prodotto di una degenerazione della purezza originaria, e poste cosi le cose, la battaglia contro la civiltà andava combattuta con armi nuove, non più trattate dall'arsenale della ragione (che è prodotta dalla medesima degenerazione), ma far prevalere le armi del sentimento, della natura. La natura stessa, contrapposta all'artificio della storia appariva oscura, informe, misteriosa: non si lascia catturare da forme precise e nette, ma travolge lo spettatore con visioni grandiose e sublimi. Per questo non si descrive la bellezza della natura, ma la si sperimenta direttamente, la si intuisce lanciandovisi dentro. I significati classici di bellezza, dunque, sono definitivamente ridiscussi e si giunge a ipotizzare, come accadrà in Victor Hugo, che siano la molteplicità delle cose brutte, e non l'armonia della bellezza, le sole capaci di dire la complessità dell'arte. Anche Baudelaire, esaltando il senso simbolico del bello, ne afferra anche la contingenza e di conseguenza la pluralità di modi e categorie attraverso le quali la sua forza può esplicarsi. La bellezza apollinea è ormai attraversata, come dimostra la Nascita della tragedia di Nietzsche, da un impulso dionisiaco, spirito di ebrezza e di trasgressione eccedente. Con quest'opera si chiude il secolo dei romantici e si saluta da vicino il Novecento portando in eredità la distruzione dell'idea classica del bello e della sua autonoma pienezza simbolica. Elementi che avranno pieno compimento nel corso di tutto XXI sec., ma che già, all'epifania del nuovo secolo, trovarono nuova linfa nei movimenti d'avanguardia: Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo, Futurismo contestarono fermamente la possibilità di una forma assoluta per il bello e ancor più radicalmente negarono che l'arte possa trovare nella bellezza un principio di sintesi o di definizione. giovanni bertuccio |
AutoreGiovanni Bertuccio Archivi
Gennaio 2022
Categorie
Tutti
|
ART IS PRESENT
Art is Present
|
 Feed RSS
Feed RSS