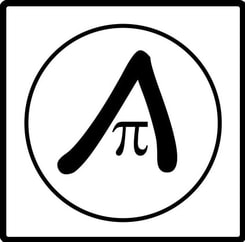|
Si forma l’orientamento sessuale nell’essere umano? Nel Ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910), esaminando dipinti e carteggi del grande artista, Freud ipotizza che l’omosessualità dell'artista sia da collegare al vincolo erotico precoce con la madre. Un attaccamento intenso che non verrà rimosso, e non sostituito con quello verso altre donne, ma che si conserverà nell’inconscio. Per Freud, un omosessuale di questo tipo si mette al posto della madre e sceglie ragazzi simili a lui da amare, come la madre ha amato lui.
|
Autore
Giovanni Bertuccio
Archivi
Gennaio 2022
Gennaio 2021
Gennaio 2020
Settembre 2019
Marzo 2019
Gennaio 2019
Ottobre 2018
Giugno 2018
Maggio 2018
Aprile 2018
Gennaio 2018
Marzo 2017
Dicembre 2016
Novembre 2016
Ottobre 2016
Settembre 2016
Luglio 2016
Giugno 2016
Maggio 2016
Categorie
Tutti
Action Painting
AIDS
Anna Halprin
Annibale Ruccello
ANNI NOVANTA
Anni Sessanta
Arnulf Rainer
Art Brut
Arte
Arte Dei Folli
ARTE E STRADA
ARTE RELAZIONALE
Artivisive
Azioni
Bodyart
CAMP
Cibele
CIRCO VERTIGO
CLAUDIO ZANOTTO CONTINO
COMPORTAMENTO
COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI
Coreografi
Corpo
CORPO E TEATRO
Cromosomi
Cubo Teatro
Danza
DANZA CONTEMPORANEA
Danza Di Comunità
Danza Di Comunità
DANZA URBANA
DES Danza Educazione Società
Drag
EGRIBIANCODANZA
FESTIVAL
FLIC TEATRO
Franca Zagatti
Gender
Genere
Genetica
GRAFFITISMO
Graphic Novel
Gunter Brus
Hans Prinzhorn
Hermann Nitsch
Il Teatro Dell'altro
Informale
INTERPLAY FESTIVAL
Interviste
ITALIA
Jean Claire
Jean Dubuffet
JEFF KOONS
Judson Dance Theate
Kunst Und Revolution
LACAN
La Nuova Drammaturgia Napoletana
L'art Chez Les Fous
Lesbismo
Luca Silvestrini
Malerei-Selbstbemalung-Selbstverstumme-lung
Mario Mieli
MICHEL FOUCAULT
Monique Witting
MOSTRE
NATURA IN MOVIMENTO
Nicola Galli
NICOLAS BOURRIAUD
NOVECENTO
ORLAN
Otto Muehl
Otto Muhl
Performance
Pollock
PROGETTO ORESTE
Protein Dance Company
PSICODRAMMA
QUEER
Queer E Arte
Queer E Danza
Queer E Teatro
Registi
Renato Barilli
Riti Di Passaggio
Riti Orgistici
Rito E Danza
RUDOLF LABAN
SILVIA BATTAGLIO
STRADA E ARTE
STREET ART
STREET DANCE
Taurobolio
Teatro
TEATRO A CORTE
Teatro Di Orge E Misteri
TEATRO DI STRADA
Teatro Sociale
TECNOLOGIA
TORINO
TRACEY EMIN
Videoart
Videoinstallazione
VUCCIRIA TEATRO
Walter Benjamin
Wiener Aktionisten
Willi Ninja
Wolfli

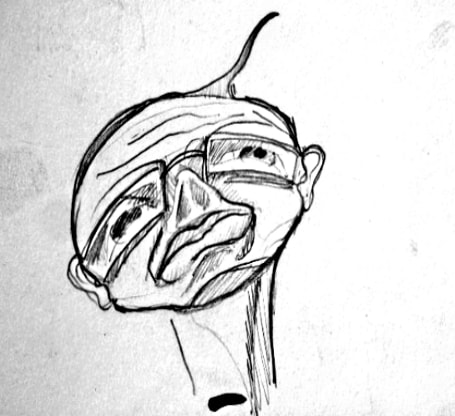
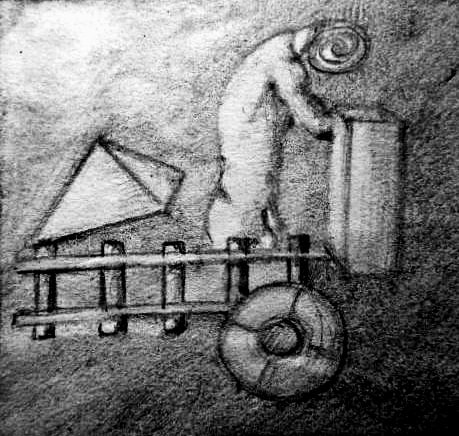

 Feed RSS
Feed RSS