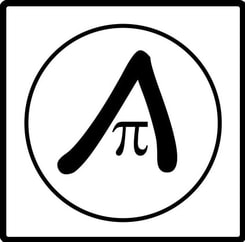|
Benjamin, nel suo saggio L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica del 1936 affermava: “ciò che sfiorisce nell’era della riproduzione tecnica è l’aura che circonda l’opera d’arte”. Come per Baudelaire, anche per il sociologo viene a mancare “l’hic et nunc dell’opera, la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova”. In questo modo, l’arte, perdendo la sua aurea perde anche il fascino legato alla sua presenza misteriosa e lontana, per diventare alla portata di tutti. La decadenza dell’aurea si fonda su due elementi: rendere le cose spazialmente e umanamente più vicine e superare l’unicità di qualsiasi dato mediante la ricezione della sua riproduzione. Venendo meno l’autenticità dell’opera cambia la funzione dell’arte stessa, passando da quella rituale a una funzione politica di dissacrazione, di denuncia e di comunicazione sociale. In questa tendenza si collocano movimenti come quello dadaista, in cui, per la prima volta, l’opera d’arte è rappresentata da un concetto, da una forma mentale e non da un’immagine. I dadaisti attraverso uno spietato annientamento dell’aurea dei loro prodotti, ai quali, coi mezzi della produzione imponevano il marchio della riproduzione, volevano suscitare la pubblica indignazione. Di fronte a un’opera dada non si viene rapiti, non ci si ferma in contemplazione ma si rimane violentemente scandalizzati. Con Duchamp un orinatoio diventa una Fontana e assume l’appellativo di opera d’arte. O con la Pop Art e Manzoni sono considerati arte, 90 barattoli di conserva, prodotti in serie, con un’etichetta riportante la dicitura: Merda d’Artista. La materia è opera d’arte.
|
AutoreGiovanni Bertuccio Archivi
Gennaio 2022
Categorie
Tutti
|
ART IS PRESENT
Art is Present
|

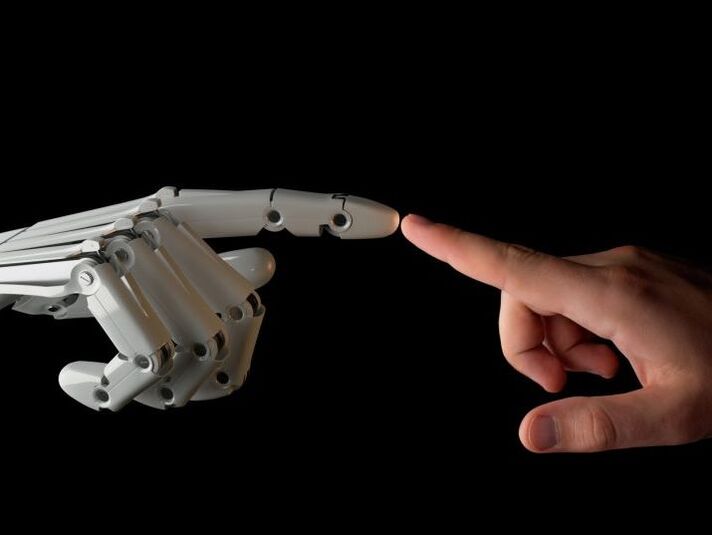

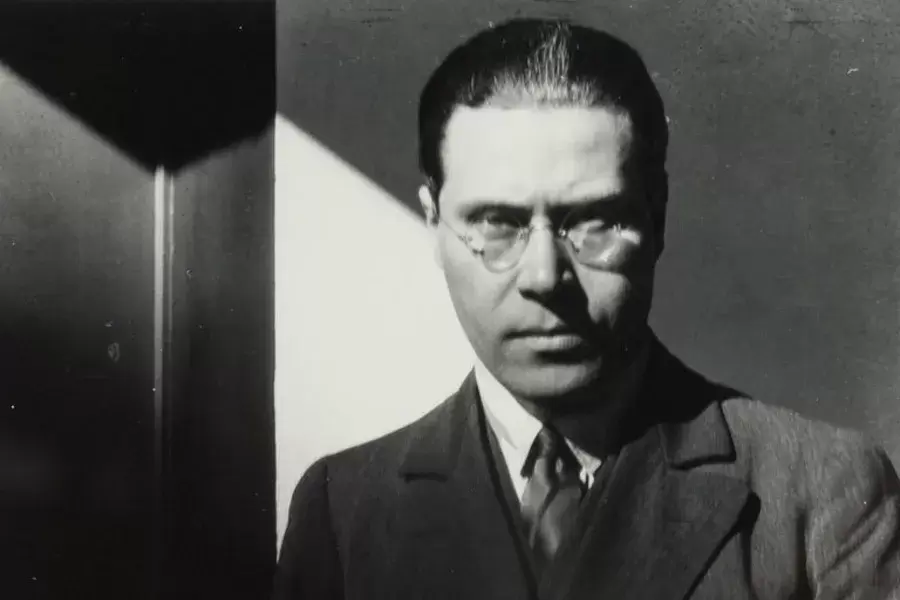

 Feed RSS
Feed RSS