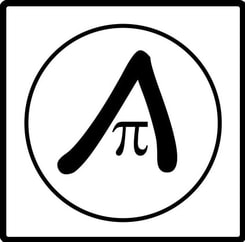|
Proprio nel momento in cui le produzioni cinematografiche stanno progressivamente abbandonando la pellicola a favore dell’HD, nel settore videomusicale e in varie esperienze videoartistiche ritorna la pellicola, oltre all’HD, come uno dei supporti possibili da usare. Insomma, nel settore dell’arte contemporanea la videoarte riparte da zero, ovvero dal cinema.
RIPARTIRE DAL CINEMA
Ritornano il set, la troupe e anche alcuni generi trattati, dal punto di vista linguistico, in modo molto classico, come il documentario, spesso intriso di autobiografia, come per esempio nelle produzioni di Shirin Neshat, o nelle videoinstallazioni di Eija-Liisa Ahtila, veri e propri docu-fiction frazionati in vari schermi, come If 6 Was 9, del 1999, o infine in alcune produzioni di Doug Aitken, dove la rappresentazione documentaristica del paesaggio, naturale o industriale, diventa un tema ossessivo.
Il riferimento, spesso nostalgico, alla memoria del cinema e dei suoi divi diffonde una vera e propria cinefilia di ritorno, come in 24 Hours Psycho di Douglas Gordon (1993), dove il film di Alfred Hitchcock viene rallentato fino a diventare, appunto, lungo 24 ore. Mentre in Telephones (1995) e The Clock (2010) di Christian Marclay si ripresenta l’estetica del found footage rimontato.
Ritorna il feticismo nei confronti della pellicola come materiale, per esempio nell’opera di Tacita Dean, che lavora rigorosamente in 16mm ed espone una videoinstallazione dal titolo più che paradigmatico, Film (2011), proiettando immagini su un’enorme struttura verticale a forma, appunto, di pellicola.
Oppure si recupera l’immagine della sala cinematografica in The Muriel Lake Incident (1999) di Janet Cardiff, dove l’installazione consiste nell’inserimento di un piccolo modello di cinematografo dentro una struttura di legno con un’apertura che l’osservatore può usare per guardare all’interno.
FILM
Al contrario, altri artisti creano un’estetica che manda in corto circuito la formula video monocanale con quella più tradizionalmente cinematografica. È il caso di Matthew Barney che fra il 1999 e il 2002 realizza un mastodontico progetto The Cremaster Cycle, formato da cinque episodi.
Il modello linguistico sul quale Barney lavora è una sorta di cinema liquido, ipnotico, dove tutto accade lentamente senza che vengano applicati effetti di rallentamento. Le riprese, girate con una cura maniacale della fotografia fino a risultare patinate, non subiscono nessun tipo di trattamento se non di correzione del colore.
I video di Barney sono la rappresentazione quasi estatica di alcune situazioni visive che lavorano sulla ricchezza di elementi delle scenografie, sulle azioni dei performer, sulle loro mutazioni e sui loro costumi. Con lo stesso approccio è realizzato uno degli ultimi video, Drawing Restraints 9 (2005), ritratto rituale dell’incontro con la musicista islandese Björk.
FILM DA CAMERA
Il video monocanale diventa così una videoinstallazione a schermo singolo, che entra nelle case di chi la acquista come un flusso audiovisivo su un monitor piatto, che può essere usato come un quadro. Che poi il formato finale sia ovviamente digitale, non importa, perché viene percepito e definito anche dagli addetti ai lavori come un “film”, o una foto in movimento.
Nasce un genere che potremmo chiamare film da camera, piuttosto lontano dalle istanze linguisticamente rivoluzionarie e sperimentali della videoarte.
gb
APPROFONDIMENTI
TECNOLOGIA E ARTE
Autore
Giovanni Bertuccio
Archivi
Gennaio 2022
Gennaio 2021
Gennaio 2020
Settembre 2019
Marzo 2019
Gennaio 2019
Ottobre 2018
Giugno 2018
Maggio 2018
Aprile 2018
Gennaio 2018
Marzo 2017
Dicembre 2016
Novembre 2016
Ottobre 2016
Settembre 2016
Luglio 2016
Giugno 2016
Maggio 2016
Categorie
Tutti
Action Painting
AIDS
Anna Halprin
Annibale Ruccello
ANNI NOVANTA
Anni Sessanta
Arnulf Rainer
Art Brut
Arte
Arte Dei Folli
ARTE E STRADA
ARTE RELAZIONALE
Artivisive
Azioni
Bodyart
CAMP
Cibele
CIRCO VERTIGO
CLAUDIO ZANOTTO CONTINO
COMPORTAMENTO
COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI
Coreografi
Corpo
CORPO E TEATRO
Cromosomi
Cubo Teatro
Danza
DANZA CONTEMPORANEA
Danza Di Comunità
Danza Di Comunità
DANZA URBANA
DES Danza Educazione Società
Drag
EGRIBIANCODANZA
FESTIVAL
FLIC TEATRO
Franca Zagatti
Gender
Genere
Genetica
GRAFFITISMO
Graphic Novel
Gunter Brus
Hans Prinzhorn
Hermann Nitsch
Il Teatro Dell'altro
Informale
INTERPLAY FESTIVAL
Interviste
ITALIA
Jean Claire
Jean Dubuffet
JEFF KOONS
Judson Dance Theate
Kunst Und Revolution
LACAN
La Nuova Drammaturgia Napoletana
L'art Chez Les Fous
Lesbismo
Luca Silvestrini
Malerei-Selbstbemalung-Selbstverstumme-lung
Mario Mieli
MICHEL FOUCAULT
Monique Witting
MOSTRE
NATURA IN MOVIMENTO
Nicola Galli
NICOLAS BOURRIAUD
NOVECENTO
ORLAN
Otto Muehl
Otto Muhl
Performance
Pollock
PROGETTO ORESTE
Protein Dance Company
PSICODRAMMA
QUEER
Queer E Arte
Queer E Danza
Queer E Teatro
Registi
Renato Barilli
Riti Di Passaggio
Riti Orgistici
Rito E Danza
RUDOLF LABAN
SILVIA BATTAGLIO
STRADA E ARTE
STREET ART
STREET DANCE
Taurobolio
Teatro
TEATRO A CORTE
Teatro Di Orge E Misteri
TEATRO DI STRADA
Teatro Sociale
TECNOLOGIA
TORINO
TRACEY EMIN
Videoart
Videoinstallazione
VUCCIRIA TEATRO
Walter Benjamin
Wiener Aktionisten
Willi Ninja
Wolfli

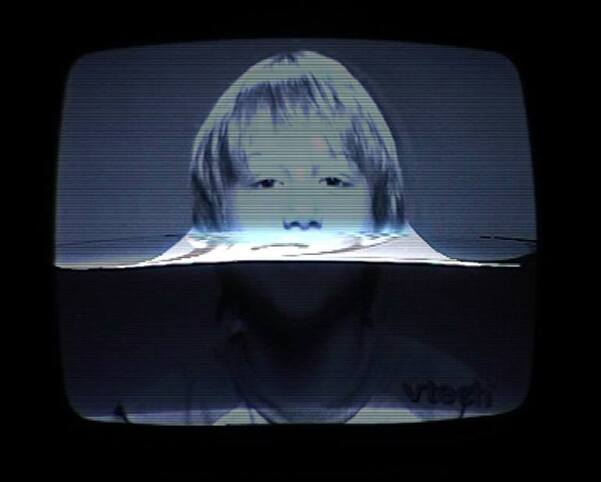

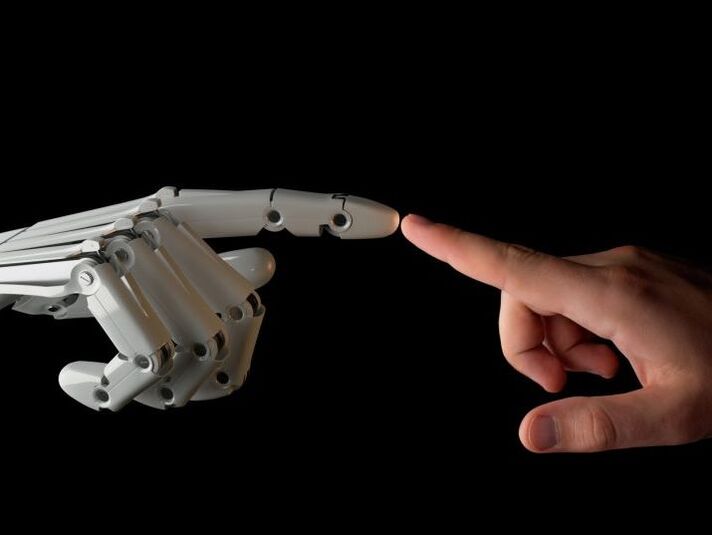
 Feed RSS
Feed RSS