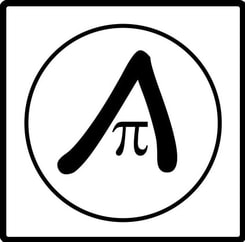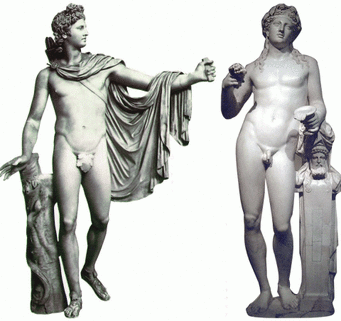 Secondo la mitologia, Zeus avrebbe assegnato una misura appropriata e un giusto limite ad ogni essere: il governo del mondo coincide cosi con un'armonia precisa e misurabile, espressa nei quattro motti scritti sulle mura del tempio di Delfi: “il più giusto è il più bello, osserva il limite, odia hybris (tracotanza), nulla in eccesso”. Su queste regole si fonda il senso comune greco della bellezza, in accordo con una visione del mondo che interpreta l'ordine e l'armonia come ciò che pone un limite allo “sbadigliante caos”, dalla cui gola è scaturito, secondo Esiodo, il mondo. È una visione posta sotto la protezione di Apollo, che infatti viene raffigurato tra le Muse sul fronte occidentale del tempio di Delfi. Ma nello stesso tempio (risalente al IV sec. a.c.) è raffigurato, sul fronte opposto, Dionisio, dio del caos e della sfrenata infrazione di ogni regola. Questa compresenza di divinità antitetiche non è casuale. In generale essa esprime la possibilità, sempre presente, di un interruzione del caos nella bella armonia. Più specificatamente, si esprimono qui alcune antitesi. Una prima antitesi è quella fra bellezza e percezione sensibile. Se infatti la bellezza è si percepibile, ma non completamente, perché non tutto di essa si esprime in forme sensibili, si apre una pericolosa forbice tra apparenza e bellezza: forbice che un filosofo della portata di Eraclito ha aperto affermando che la bellezza armonica del mondo si palesa come causale disordine. Una seconda antitesi è quella tra suono e visione, le due forme percettive privilegiate della percezione greca: benché si riconosca alla musica il privilegio di esprimere l'anima, e solo alle forme visibili che si applica la definizione di bello (kalòn) come “ciò che piace e attrae”. Disordine e musica vengono cosi a costruire una sorta di lato oscuro della bellezza apollinea armonica e visibile, e come tali ricadono nella sfera di azione di Dionisio. Questa differenza è comprensibile se si pensa che una statua doveva rappresentare un'”Idea”, mentre la musica era intesa come qualcosa che suscita passioni. L'arte greca e quella occidentale in generale privilegiano infatti, diversamente da certe forme artistiche orientali, la giusta distanza dall'opera, con la quale non si entra in contatto diretto. La bellezza greca viene cosi espressa dai sensi che lasciano mantenere distanza tra l'oggetto e l'osservatore: vista e udito piuttosto che tatto, gusto, olfatto. Ma le forme udibili, come la musica, suscitano sospetto, per il coinvolgimento che comportano nell'animo dello spettatore. La bellezza apollinea si presenta come uno schermo che cerca di cancellare la presenza di una bellezza dionisiaca, conturbante, che non si esprime nelle forme apparenti, ma aldilà delle apparenze. … i due impulsi così diversi procedono uno accanto all'altro, per lo più in aperto dissidio tra di loro e con un 'eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e più robusti, per perpetuare in essi la lotta di quell'antitesi, che il comune termine “arte” solo apparentemente supera […] Per accostarci di più a quei due impulsi, immaginiamoli innanzitutto come mondi artistici separati del sogno e dell'ebrezza […] come forze artistiche erompono dalla natura stessa senza mediazione dell'artista umano, e in cui gli impulsi artistici della natura trovano anzitutto e in via diretta soddisfazione: da una parte come immagini del sogno, la cui perfezione è senza alcuna connessione con l'altezza intellettuale o la cultura artistica del singolo; d'altra parte come realtà piena di ebrezza, che a sua volta non tiene conto dell'individuo, e cerca anzi di annientare l'individuo e di liberarlo con un sentimento mistico di unità. Apollo, come dio di tutte le capacità figurative è insieme il dio divinante, egli è anche il dio della bellezza, della luce e del sole. Egli è il dio dell'occhio, e infatti questo organo è quello che più di tutti gli altri fa da ponte tra il mondo esterno e quello interno, la sua sapienza è quella di ciò che vede fuori per insegnarlo all'interno. La vista, come tutti gli altri sensi, non può essere strumento obbiettivo, nel momento stesso in cui trasmette le immagini esterne all'interno, le traduce automaticamente in visione. Inoltre non è solo quella che ci aiuta a percepire il mondo esterno ma è anche il ponte attraverso il quale proiettiamo all'esterno la rappresentazione dei nostri contenuti interni, che senza questo rimarrebbero amorfi.  Al contrario di Apollo, Dionisio aveva aspetti molto diversi. In forma umana lo si rappresentava con una maschera barbuta. Era associato a Pan e ai piccoli Pan, i dei fallici e pelosi della foresta. Il dio era l'antitesi della bellezza apollinea dalle proporzioni plastiche perfette, e rappresentava gli eccessi, l'ebrezza, la sfrenatezza, la perdita di controllo e l'orgiastico. Durante le feste in suo onore le Bacchanalia (Dyonisia) le donne abbandonavano le proprie famiglie, andavano sui monti vestite di pelli di fauno e gridavano “Euoi”, il grido rituale. Formavano delle bande sacre (thyasi) e danzavano alla luce di fiaccole al ritmo del flauto e del tympanon. Mentre erano sotto l'ispirazione del dio avevano forze occulte, l'abilità di incantare i serpenti, e forze sovrumane che permettevano loro di dilaniare gli animali vivi e sbranarli (omophagia). Le baccanti gridavano il suo nome come Bromios (il tuonante), Tautokeros (dalle corna di toro), Tauroprosopos (dalla faccia di toro), nella credenza che incarnasse un animale sacrificale. Appariva spesso in veste di vari animali, tutti pelosi e generalmente selvatici. Nelle raffigurazioni arcaiche viene rappresentato come un uomo barbuto, un Sileno, e solo in epoca ellenista, quando Apollo avrà preso definitivamente la preminenza, come giovane effeminato. Gli artisti rappresentavano i satiri con peni esuberanti e ci sono pitture vasarie del VI e V secolo che li rappresentano con erezioni della grossezza di un braccio; anche nelle commedie di satiri il pene portato dai membri del Coro era in erezione. Alcune feste greche, comprese le Dionisiache cittadine e quelle rurali in Attica, comprendevano una processione in cui veniva portato un fallo in onore di Dionisio. Dionisio-Pan, aveva anticipato Apollo nelle nebbie delle steppe che avevano preceduto l'Olimpo greco, condensa l'antitesi di quelle che saranno le peculiarità del dio delfico, e simboleggia l'alter ego delle soluzioni apollinee. Entrambi divini poiché questi sono i poli di un'unica equivalenza. Con la rimozione completa della propria realtà esistenziale tribale, all'interno della società greca, si creò una scissione tra le due divinità che assunse una connotazione normativa. Apollo diventò, sempre di più, anche il simbolo di un ordine morale e con il progredire dei secoli, la divergenza tra questi due dei si accentuò sempre di più, fino a diventare il simbolo, uno del bene assoluto, l’altro del male assoluto. Il cristianesimo, spinse questa divergenza, da quella che una volta era stata un’equivalenza, ai suoi estremi, fino a tradurre l’immagine di Apollo, astro principale dell’universo, in quella del Cristo, e quella di Dioniso, demone caprino e peloso dagli istinti sfrenati, in quella del Diavolo. 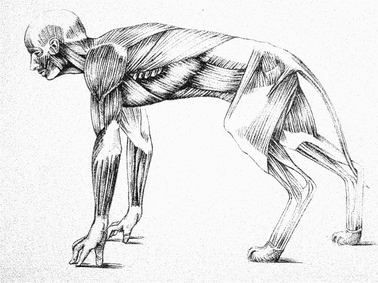 Simbolo di luce e di giustizia e, quindi, di equilibrio e di moralità l’uno; simbolo di oscure macchinazioni e, quindi, di sfrenatezza e d’immoralità, l’altro. Con il prevalere dell’apollineo la “conoscenza” dell’immanenza pulsionale dionisiaca viene rimossa, relegata ai misteri, feudo esclusivo di un’élite di iniziati guardati con sospetto, forse come lo sono i massoni dei giorni nostri, e tale deve rimanere: un mistero. La musica orgiastica dionisiaca, la danza sfrenata e persino la tragedia eschilea vengono relegate all’opposto e diventeranno l’antitesi di quello che è socialmente desiderabile, al punto che Platone suggerisce di proibirle nel suo stato ideale, cosi come propone di proibire Omero e di censurare i miti greci che raccontano di cose “sconvenienti”. Tuttavia i riti legati a Dioniso, continuarono a venire festeggiati, come nelle dionisiache rurali e cittadine, e persino vi era una città sacra denominata Dionysia dove ogni sorta di svaghi e orge venivano celebrate all’insegna del dio. In epoca ellenista un teatro fu edificato in suo onore sull’Acropoli di Atene, ma quella che ai tempi di Eschilo era ancora una tragedia divenne commedia e in questo teatro si festeggiava sempre meno la sacralità e sempre di più la scurrilità del dio. La gente non andava più a teatro per esperimentare sulle proprie membra la passione del pasto totemico nel tremore dell’identificazione e della catarsi bensì per svagarsi: le commedie dei satiri, un cabaret parallelo ad ogni società in decadenza, e le rappresentazioni teatrali all’insegna di Dioniso prolificavano come i nigth-clubs di Parigi o della Berlino tra le due guerre. Divenne un dio della fertilità, come quelli semiti celebrati in tutto l’oriente ellenizzato: Attis, Adonis, Tammuz. Diventò improvvisamente un dio “orientale”, come quelli che morivano alla fine della primavera per risuscitare in autunno, quando nel Medio Oriente le prime piogge riportano alla vita la natura, che era rimasta arida sotto il solleone estivo. 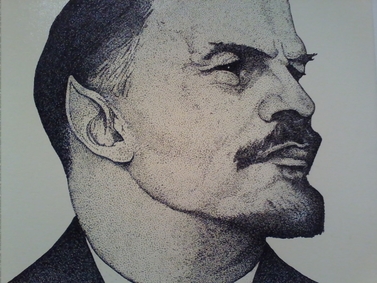 Dalla metà del V secolo in poi divenne un dio con il quale l’anima greca avrà sempre più difficoltà a identificarsi. Sempre meno dio e sempre più satiro, nel senso volgare della parola. La morte sociale di Dioniso trascinerà con se anche l’agonia di Apollo. Il dio defico senza un’equivalenza antitetica perderà anche lui di intensità vitale. La sua massima espressione, la saggezza comunicata per enigmi, transustazione dell’arcaica conoscenza comunicata ai giovani attraverso il rito iniziatico puberale, diventa attraverso la razionalizzazione della filosofia, “verità ideale”. L’arte occidentale, dopo essere arrivata ai suoi apici nella fusione delle energie dionisiache con il medium visivo del dio delfico, dal IV secolo in poi comincia a decadere. Il regno di Fidia e di Prassitele viene sostituito da quello di Platone e di Aristotele. La filosofia viene al posto dell’arte, come strumento di rimozione e di razionalizzazione. Apollo aveva vinto, ma era molto, molto stanco. Il processo era stato lento ma letale. Se il modus mentale apollineo aveva portato alla democrazia della polis greca come sviluppo naturale del bisogno di libertà ispirato da Apollo come conseguenza del superamento del rito tribale e della Legge del Padre, ecco che Platone vuole codificare delle regole precise, vuole farne una repubblica ideale, e introdurre così dalla porta posteriore una censura e una regolamentazione che sono proprio l’antitesi dello spirito di libertà della polis greca. Come già, per Platone, il bello era stato il parametro per costruire i suoi schemi filosofici, questi fanno presto a diventare una fede. Quando nella Grecia arcaica il dio delfico dall’interno del suo tempio si pronunciava per enigmi, le sue sentenze oscure alludevano che solo i degni, gli iniziati alla vera essenza del dio avrebbero potuto decodificarne i significati: eravamo ancora ben lungi dalla filosofia socratica e le sue catene di sillogismi. Con Platone lo schema è pronto: il filosofo, ispiratosi al bello, che come abbiamo visto è l’antitetico del brutto, il capro, filosoferà su quello che è buono o malvagio, giusto o ingiusto. Il filosofo diventa così il nuovo sacerdote di Apollo. La sua aspirazione è tradurre i suoi postulati filosofici in articoli di fede: siamo già alle soglie del dogma. Se Platone sa di poter distinguere tra il bene e il male, teme però che non tutti riceveranno i suoi postulati, e non si accontenta di diffondere la sua scienza, vuole imporla come unico schema politico. I filosofi della sua Repubblica non sono più dunque come l’oracolo di Apollo, che viene consultato volontariamente da chi vuole essere illuminato attraverso il medium della sacralità del dio, bensì una classe politica detentrice della verità assoluta. giovanni bertuccio |
AutoreGiovanni Bertuccio Archivi
Gennaio 2022
Categorie
Tutti
|
ART IS PRESENT
Art is Present
|
 Feed RSS
Feed RSS